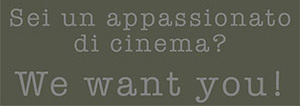INDIE GIRLS
 Se davvero non avete mai visto un film di Noah Baumbach, uno dei registi più interessanti emersi negli ultimi anni, vi diamo la possibilità di coglierne l’essenza con questa breve rassegna, creata in occasione dell’uscita di Lady Bird, primo film da regista di Greta Gerwig, attrice, co-autrice, compagna, e musa ispiratrice di Baumbach, nonché icona del cinema indipendente americano. Indie Girls vuole essere un omaggio a questo cinema e a questi irresistibili personaggi che, parafrasando Salinger, usciti dal cinema li vorreste come i vostri amici per la pelle e poterli chiamare al telefono tutte le volte che vi gira. In questi tre film domina il tema del passaggio all’età adulta, con giovani donne determinate, difficili, con un punto di vista sul mondo personale, aspiranti artiste che devono fare i conti con la realtà, col diventare adulte e il doversi adattare alle regole della società. Donne colte nel momento di massima vulnerabilità, in cui il senso di chi sono o cosa fanno si trova a un punto di svolta: cambiare o restare se stesse; divise tra quello che sono e quello che potrebbero, o avrebbero potuto, essere. Sono film che ci parlano di un certo mondo, della scena newyorkese, ma hanno dei tratti universali, perché il senso di inadeguatezza e di ansia sociale che è perennemente presente è qualcosa con cui le nuove generazioni non fanno fatica a identificarsi.
Se davvero non avete mai visto un film di Noah Baumbach, uno dei registi più interessanti emersi negli ultimi anni, vi diamo la possibilità di coglierne l’essenza con questa breve rassegna, creata in occasione dell’uscita di Lady Bird, primo film da regista di Greta Gerwig, attrice, co-autrice, compagna, e musa ispiratrice di Baumbach, nonché icona del cinema indipendente americano. Indie Girls vuole essere un omaggio a questo cinema e a questi irresistibili personaggi che, parafrasando Salinger, usciti dal cinema li vorreste come i vostri amici per la pelle e poterli chiamare al telefono tutte le volte che vi gira. In questi tre film domina il tema del passaggio all’età adulta, con giovani donne determinate, difficili, con un punto di vista sul mondo personale, aspiranti artiste che devono fare i conti con la realtà, col diventare adulte e il doversi adattare alle regole della società. Donne colte nel momento di massima vulnerabilità, in cui il senso di chi sono o cosa fanno si trova a un punto di svolta: cambiare o restare se stesse; divise tra quello che sono e quello che potrebbero, o avrebbero potuto, essere. Sono film che ci parlano di un certo mondo, della scena newyorkese, ma hanno dei tratti universali, perché il senso di inadeguatezza e di ansia sociale che è perennemente presente è qualcosa con cui le nuove generazioni non fanno fatica a identificarsi.
giovedì 22 marzo, ore 21
Frances Ha
Di Noah Baumbach. Con Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Commedia drammatica, 86 min. – USA 2012
Essere identificati con un’intera corrente artistica non è mai facile, soprattutto quando si parla di cinema indie. La sola parola, oggi, fa rovesciare gli occhi a molti spettatori navigati, che in esso vedono un coacervo di pretenziosità e autocompiacimento dove si ripetono sempre gli stessi tópoi narrativi, al punto da reiterare persino le atmosfere, i colori, l’abbigliamento e gli scenari urbani o suburbani. Greta Gerwig, suo malgrado, è considerata l’emblema di tutto questo, ma soltanto un fiero detrattore potrebbe limitarsi a uno sguardo così superficiale: il successo dell’attrice californiana – ora anche autrice – cela infatti un desiderio di (auto)rappresentazione che riecheggia in molte branche del pubblico, soprattutto nella fascia che spazia tra la pubertà, la post-adolescenza e i primissimi anni dell’età adulta, ammesso che questa distinzione abbia ancora senso. E, guardando il cinema di Greta Gerwig, forse non ne ha più.
Non è un caso che le protagoniste di Lady Bird e Frances Ha siano originarie di Sacramento, città natale dell’autrice, e poi si trasferiscano a New York per studiare o lavorare: il loro percorso rispecchia quello della stessa Gerwig, che attinge a varie suggestioni autobiografiche (non necessariamente letterali) al fine di renderle universali, proponendosi come la voce di un’intera generazione. In fondo, certi aspetti generali della sua esperienza sono piuttosto comuni tra i giovani americani, soprattutto quelli che nascono lontani dai grandi centri culturali e artistici degli Stati Uniti. Come l’eponima eroina del suo debutto registico, anche lei cresce nella città californiana e coltiva il sogno di trasferirsi a New York, dove vorrebbe studiare teatro musicale: un desiderio che nasce dalle sue esperienze nella danza, soprattutto il balletto e poi l’hip hop, più consono alla sua notevole statura corporea. Dopo aver frequentato il liceo cattolico femminile di St. Francis, Gerwig emigra nella Grande Mela, ma finisce per laurearsi in inglese e filosofia al Barnard College. Cerca di dedicarsi alla scrittura drammaturgica (aveva già firmato alcune commedie durante l’università), ma non viene ammessa ai corsi del Master of Fine Arts, quindi si concentra di più sulla recitazione. Una mossa vincente: Greta entra in contatto con Joe Swanberg, principale esponente del mumblecore, che le assegna un piccolo ruolo nel suo secondo film da regista, LOL (2006).
Considerando la successiva evoluzione della sua carriera, non sorprende che Greta Gerwig abbia iniziato proprio con il mumblecore. Questo sottogenere del cinema indie si fonda su alcune caratteristiche ricorrenti, in particolare la recitazione naturalistica, i budget microscopici e i dialoghi spesso improvvisati (da cui il “borbottio” – in inglese mumble – che dà il nome al movimento), ed è l’erede ideale del cinema di John Cassavetes e del primo Richard Linklater, soprattutto il suo Slacker. Gerwig si “forma” in questa filosofia produttiva, diventandone ben presto una figura chiave: dopo essere apparsa in Baghead dei fratelli Duplass, rafforza la sua unione creativa con Swanberg e collabora alla sceneggiatura di Hannah Takes the Stairs (2007), prima di debuttare alla regia – ma in coppia con lo stesso Swanberg – in Nights and Weekends (2008). Partecipa anche ad altri film indipendenti, tra cui l’horror The House of the Devil (2009) di Ti West, ma comincia ad avvertire una certa irrequietezza che la riporta a studiare recitazione, preparandosi così per il grande salto che seguirà.
La svolta decisiva è l’incontro con Noah Baumbach, che la scrittura in Greenberg (2010) al fianco di Ben Stiller, Rhys Ifans e Jennifer Jason Leigh. Questa sinergia con il cineasta newyorkese, oltre a essere fondamentale per la sua maturazione artistica, le apre nuovi orizzonti di cinema mainstream: non a caso, dopo Greenberg, Greta Gerwig compare in Amici, amanti e… (2011), Damsels in Distress (2011), Arturo (2011) e To Rome with Love (2012), dove lavora con Woody Allen. Gli obiettivi di Greta, però, sconfinano ben oltre la recitazione; il suo obiettivo è raccontare storie anche come autrice, dirottando sul grande schermo le sue vecchie ambizioni drammaturgiche. Anche per questa ragione, il successivo Frances Ha è una creatura in gran parte sua, nonostante la regia sia curata dal solo Baumbach (al quale è legata anche sentimentalmente). Il film esce nel 2013 con un grande successo di critica, e si afferma subito come un piccolo cult: girato in bianco e nero, ispirato ai classici della Nouvelle Vague e di Woody Allen, Frances Ha cela il primo germoglio della Greta Gerwig-autrice, che infatti scrive la sceneggiatura con Baumbach e ne influenza radicalmente lo sviluppo, costellandola di spunti autobiografici che torneranno anche in seguito.
Frances Halladay è una ventisettenne di Sacramento che vive a New York con la sua migliore amica Sophie (Mickey Sumner), e si guadagna faticosamente da vivere lavorando per una compagnia di ballo e insegnando danza alle bambine. Quando Sophie decide di trasferirsi, Frances è costretta a cavarsela da sola in un sottobosco di giovani artisti – o aspiranti tali – che sembrano sempre più in gamba di lei, o comunque più bravi a badare a loro stessi. Ne deriva il ritratto di una generazione smarrita, dove i confini tra l’adolescenza e l’età adulta sono sempre più sfumati: la stessa Frances è infantile, spesso inadeguata, priva di quelle certezze professionali e finanziarie che le consentirebbero di pianificare la sua vita, mentre i “veri adulti” – già sposati, con un lavoro fisso e dei bambini – sembrano lontani anni luce. Greta Gerwig incarna così un certo tipo di ansia sociale con cui è facile relazionarsi, evocando spesso i piccoli imbarazzi quotidiani di chi si sente sempre fuori posto. Di conseguenza, Frances Ha mette in scena una protagonista che si allontana dalla retorica dell’eccezionalità (tipica di molto cinema americano), preferendole una normalità che talvolta si avvicina persino alla mediocrità: Frances non è un genio, non ha nemmeno un talento sfolgorante per la danza, eppure trova una sua nicchia di indipendenza che le permette di realizzarsi come persona. Dal contrasto fra l’inerzia di Frances e le esigenze del mondo esterno scaturisce il peculiare tono del film, sempre in bilico tra l’ironia e l’amarezza, la giocosità e l’introspezione.
Frances Ha diventa un manifesto generazionale, e la collaborazione con Baumbach prosegue in Mistress America (2015), scritto anch’esso a quattro mani. Stavolta Greta Gerwig non è la protagonista assoluta, ma interpreta Brooke, prossima sorellastra di Tracy Fishko (Lola Kirke), una matricola del Barnard College che fatica a inserirsi tra i compagni e sogna di fare la scrittrice. Tracy è affascinata dalla vita imprevedibile di Brooke, e la pone al centro di un racconto che le permette di accedere a una prestigiosa rivista letteraria. Brooke, intanto, vuole aprire un ristorante, ma perde i finanziamenti e deve rivolgersi alla sua ex migliore amica – che le rubò un’idea imprenditoriale – per trovare nuove risorse economiche. Anche in questo caso si avverte lo smarrimento dei giovani odierni davanti alle più disparate aspettative sociali ed economiche, ma Brooke è molto più “inserita” e popolare di Frances: fa parte dei cool kids, non certo degli emarginati, e la celebrazione finale che le dedica Tracy («Fare da paladina dei reietti è un lavoro solitario») non suona molto credibile rispetto alla sua caratterizzazione. Il limite di Mistress America è proprio questo: cerca di “mitizzare” un personaggio che non lo merita affatto, usando un approccio meno onesto rispetto a Frances Ha. E, pur vantando dialoghi brillanti e personaggi ben delineati, si sforza di diventare iconico a tutti i costi, perdendo naturalezza.
L’abilità recitativa di Greta, in compenso, si affina sempre di più. Quando interpreta personaggi che le sono vicini (vale anche per Il piano di Maggie di Rebecca Miller), l’attrice californiana dà sempre l’impressione di esserci e non esserci allo stesso tempo, oscillando tra il coinvolgimento emotivo e uno straniamento quasi brechtiano, che le permette di confessarsi alla macchina da presa senza mai eccedere nel melodramma. Registi importanti si accorgono di lei, e infatti lavora con Mia Hansen-Løve in Eden (2014); Todd Solondz in Wiener-Dog (2016); Mike Mills in 20th Century Women (2016); Pablo Larraín in Jackie (2016); e Wes Anderson – come doppiatrice – ne L’isola dei cani (2018).
A questo punto, il debutto alla regia in veste solitaria è un passaggio obbligato. Greta Gerwig lavora per anni alla sceneggiatura di Lady Bird (2017), attingendo alle sue esperienze nel liceo cattolico di Sacramento, ma senza riferimenti letterali: i parziali autobiografismi sono più che altro delle suggestioni, utili per far risuonare la vicenda nei ricordi dell’autrice. D’altra parte, agli aspiranti scrittori si offre sempre lo stesso consiglio: “Scrivi di ciò che conosci”. Un suggerimento che Greta ama seguire per filo e per segno nelle sue sceneggiature, e Lady Bird è un’ulteriore emanazione del suo vissuto individuale, trasfigurato e rielaborato in forma d’arte. Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) è una diplomanda di Sacramento che desidera frequentare un college dell’Ivy League, preferibilmente a New York, ma sua madre Marion (Laurie Metcalf) le fa notare che la famiglia naviga in cattive acque, e l’accusa di essere un’ingrata. Così, Lady Bird affronta l’ultimo anno di liceo tra primi amori e nuove amicizie, sfogando la sua frustrazione in modi che Marion non approva, mentre invia le applicazioni a vari college fuori dallo stato.
Il paradosso di Lady Bird è che, per raggiungere una superiore maturità espressiva, Greta Gerwig è dovuta tornare indietro nel tempo, risalendo all’epoca in cui si formano le primissime basi dell’età adulta. Ancora una volta assistiamo al ritratto di una ragazza “media”, priva di grandi talenti che la elevino dalla massa, eppure dotata di una personalità credibile e vibrante, destinata a entrare in collisione con la madre. Quello tra le due figure femminili, salde e inamovibili nelle rispettive convinzioni, è uno dei rapporti madre-figlia più verosimili che il cinema americano ci abbia regalato negli ultimi anni, perché richiama l’idea di un’incomunicabilità irrisolvibile, come dimostra il malinconico finale. Ma Lady Bird è anche una rilettura spigolosa del chick flick, dove l’educazione sentimentale e il percorso formativo della protagonista ci offrono una controparte femminile di alcuni classici Bildungsroman maschili, soprattutto I 400 colpi e Boyhood.
La strada pare già tracciata, anche perché Greta Gerwig ha manifestato un grande entusiasmo per il mestiere della regia: “Non c’è nulla di più elettrizzante di vedere grandi attori che pronunciano le parole scritte da te, dando loro vita” ha dichiarato. Il suo cinema (seppur neonato) propone una focalizzazione intimista sul femminile che risponde a un’esigenza crescente: quella di differenziare lo sguardo, proiettando sulla realtà un punto di vista alternativo a quello dominante. Che poi è la missione stessa del cinema indipendente, di cui Greta Gerwig, sul panorama americano, è ormai diventata l’emblema più popolare. (Lorenzo Pedrazzi – blog.screenweek.it)
sabato 24 marzo, ore 21
domenica 25 marzo, ore 18
domenica 24 marzo, ore 21 (versione originale con sottotitoli in italiano)
Lady Bird
Di Greta Gerwig. Con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.
Commedia – USA, 2017, durata 93 minuti.
In sala dal 1° marzo con “Lady Bird”, pluricandidato ai prossimi Oscar, la coppia Gerwig – Ronan firma una delicata storia di “coming of age” femminile, che è un po’ la rappresentazione del nuovo corso dopo Weinstein
Ancora non sappiamo come andrà a finire la notte del 4 marzo. Se Lady Bird, baluardo femminista dell’annata cinematografica in corso, strapperà qualche Oscar pesante, come ormai ci si aspetta nella Hollywood d.W. (dopo Weinstein). Con le serie televisive, ai passati Emmy e Golden Globe, è andata liscia: c’erano in lizza Big Little Lies e The Handmaid’s Tale, ispirate a libri di donne (Liane Moriarty/Margaret Atwood), prodotte e interpretate da donne (Nicole Kidman e Reese Witherspoon/Elisabeth Moss). Poi erano pure di somma qualità, soprattutto la prima, e premiarle è stato ancora più facile.
Lady Bird è scritto e diretto da Greta Gerwig, una delle più ferventi animatrici del dibattito attuale. Ha dichiarato: «Questa è una stagione incredibile per le donne che fanno cinema. C’è spazio per chi vuole girare blockbuster come Patty Jenkins con Wonder Woman, ma anche per Angelina Jolie (Per primo hanno ucciso mio padre), Maggie Betts (Novitiate), Dee Rees (Mudbound). E per il mio film, una storia universale. Visto che da sempre ci sono meno registe donne, ci sono anche meno storie di coming of age femminili.Non ho nulla contro i film di formazione con protagonisti maschi, ma mi chiedo sempre: come sarebbe Boyhood se al centro ci fosse una ragazza? E I 400 colpi?». (Truffaut preferiamo continuare a immaginarlo per il sommo capolavoro che è al di là del gender).
Lady Bird, va da sé, è il coming of age di un’adolescente americana. Si fa chiamare col nome del titolo, cerca la sua identità di liceale tra un corso di teatro e il mutuo soccorso con l’amica grassoccia, si sente stretta nella provincia immobile, sfida mamma e papà (fin troppo comprensivi), scopre come ci si comporta coi maschi (e, soprattutto, come i maschi si comportano con lei). Non è tratto da nessun libro, ma viene scomodata una frase di Joan Didion, concittadina della fittizia protagonista (e della vera Gerwig): «Chiunque parli dell’edonismo della California non ha mai passato un Natale a Sacramento».
Una volta lo si sarebbe detto “un film da Sundance”: hipster (anche se un tempo non si diceva così), furbetto, citabilissimo, fintamente controcorrente e in realtà confortante, le sciure che ancora vanno al cinema di pomeriggio lo definirebbero «carino». Oggi l’ex operina indipendente è diventata la prassi del cinema d’autore statunitense. Quand’è che è cominciato tutto? Da Little Miss Sunshine, col suo furgone Volkswagen e il nonno saggio? Da Sideways, consacrazione mainstream di Alexander Payne? Dalle sceneggiature bobo di Noah Baumbach (oggi, peraltro, fidanzato di Gerwig)? Non c’è una soluzione matematica al problema, certo è che Lady Bird segue quel solco, e a suo modo trionfa.
Il cinema indie-pop, chiamiamolo così, ha poi bisogno delle sue testimonial. Di attrici ne abbiamo avute a infinite tornate, andando con la memoria agli ultimi quindici anni saltano fuori Maggie Gyllenhaal, Zooey Deschanel, Juno Temple, Zoë Kravitz, Brie Larson, naturalmente la stessa Greta Gerwig.
La nuova eroina è Saoirse Ronan, la Lady Bird del titolo. Newyorkese ma di genitori irlandesi, nome gaelico (la pronuncia è, più o meno, Sórscia), già due candidature all’Oscar prima di quest’ultima: a quattordici anni come non protagonista per Espiazione (da Ian McEwan), a ventidue come protagonista per Brooklyn (da Colm Tóibín). Il secondo è un po’ la stessa storia di Lady Bird, solo ambientata negli anni Cinquanta della grande emigrazione: la timida Irish girl salpa per l’America, crede che un buon matrimonio sia sufficiente per trovare un posto nel mondo, in realtà scopre che la cosa più importante è l’affermazione di sé.
In Lady Bird succede lo stesso, e Saoirse è assai credibile a fare, a ventitré anni, la studentessa in attesa del college, ha la faccia giusta da nuova Hollywood, insieme a Greta Gerwig porta in giro questo film-manifesto, già era intenzione dell’autrice farne un paradigma di educazione (femminile) alla vita, poi Hollywood ha deciso che il tempo per queste storie era giunto davvero. (Mattia Carzaniga, IL)
giovedì 29 marzo, ore 21
Mistress America
Di Noah Baumbach. Con Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear.
Commedia, durata 84 min. – USA 2015
Parla la nostra lingua, Mistress America, e c’è qualcosa nei suoi personaggi, nella loro goffa vacuità, che è un totale fallimento, forse una mezza speranza.
Noah Baumbach lo sa di essere terribilmente, insopportabilmente newyorchese, di girare film con personaggi insopportabili e newyorchesi, o forse insopportabili proprio perché newyorchesi. Lo sa perché li racconta e li mette in scena come figure ridicole, meccaniche, che più che discutere parlano con se stesse, che più che vivere assumono modelli di comportamento e provano a metterli in pratica, fallendo.
Parla la nostra lingua, Mistress America, perché parla una lingua universale e contemporanea: la parola diretta e piatta della comunicazione tutto intorno a noi; la parola superficiale che insegue senza posa la profondità e l’autenticità del racconto, rispondendo al desiderio di trasformare ogni evento, anche il più banale, nel tassello di un mosaico, nella figura di una storia.
Non parla della realtà, Mistress America, ma di come la parola, oggi, agisca sulla realtà. I suoi personaggi si incontrano, conoscono e frequentano per diventare semplice materia da romanzo, tasselli di una continua, onnipresente operazione di storytelling che cannibalizza il quotidiano. Se c’era una maniera moderna di riprendere e adattare la screwball comedy, Mistress America l’ha trovata: annientando il peso delle parole; replicando lo svilimento o, al contrario, l’eccessiva simbolizzazione a cui sono sottoposte. Trasformando, ancora, le parole nell’unica discriminante di relazioni in cui si parla e si scrive di continuo, ma non si va mai a fondo, si resta alla lettera, incapaci di leggere fra righe ingombre di testo.
La New York di Baumbach è un gigantesco eufemismo: sta per qualcos’altro, ma sa sempre e solo essere se stessa. Realtà e racconto sono appaiati, immediati, senza più scarto temporale fra l’una e l’altro, in un tutt’uno indiscriminato e indistinguibile. La realtà ha senso solo se trasformata in materiale di seconda mano: in racconto, per l’appunto, o commento, post, battuta. Come se vivere servisse a raccontare.
Tracy, la protagonista ventenne di Mistress America, non vive, osserva le vite degli altri. E quando trova nella trentenne Brooke un’amica, la trasforma nella protagonista del proprio racconto. Senza mediazione tra il vissuto e la sua elaborazione. E la stessa Brooke, già vecchia alla sua età, ossessionata da modelli a cui si appiccica, si comporta come una Gatsby al millesimo, nemmeno in minore, regina di un sottobosco indie che inizia e finisce nel bar di riferimento, intellettuale e poser che alterna progetti creativi a lezione in palestra, che flirta con il disastro ma non sa fare altro.
All’inseguimento del tempo come i personaggi di Giovani si diventa, Brooke (che come la sua interprete Greta Gerwig appartiene a una generazione ancora precedente rispetto a quella del quasi cinquantenne Baumbach, così avulso dal mondo dei suoi ultimi film da raccontarlo come un elefante, come un convitato di pietra che ha sfasciato ogni cosa) è convinta di vivere nell’attimo della propria giovinezza, capace sì di gettare la maschera ma bene al sicuro dietro le proprie convinzioni.
“Doing something depressing, but young”, dice a un certo punto al padre, sintetizzando come meglio non potrebbe la condizione stupida e ridicola, eppure così comune, di prigioniera del proprio mondo. Prigioniera di un parola, di una messinscena perenne, di un pubblico che la guardi, la giudichi, la assolva e la protegga. Forse per questo, in Mistress America, tutti parlano come se leggessero un gobbo, al centro del palcoscenico, come in quei programmi americani molto cool in cui le star leggono i tweet ingiuriosi che li riguardano: il tono della voce impostata e la rigidità delle figure sono le stesse.
La mezza speranza che però Baumbach intravede in questa prigione del corpo, della mente e anche dei sentimenti, è che la realtà, per quanto costantemente raccontata e quindi, almeno in prospettiva, compresa, resta pur sempre inafferrabile. Se Baumbach parla di giovani che non conosce e non capisce, è perché vede proprio in un reale cangiante il segno di una vitalità e mutevolezza che sfugge a ogni narrazione o incasellamento. Mistress America certifica la perdita di fiducia nella parola come base di ogni discorso contemporaneo: e di fronte a una sensazione di soffocamento evidente nel ritmo inutilmente concitato, si chiede se non stia proprio nel vuoto, nel fallimento dell’eterna rincorsa al tempo, la mezza speranza.
La stessa New York, in fondo, si arrende di fronte alla tirannia del tempo sullo spazio, con schiere di generazioni sempre nuove e imprevedibili (e Tracy è più giovane ancora della coppia di hipster di Giovani si diventa) che sconvolgono di continuo l’orizzonte degli atteggiamenti e delle mode – o semplicemente delle parole d’ordine da usare, dei bar giusti da frequentare – e condannano la città a restare se stessa, mutando continuamente faccia.
Mistress America parla una lingua che conosciamo così bene da non riconoscerla quando lo usiamo e la vediamo. La lingua dell’emozione trasformata in azione, del presente che riduce il passato ad archivio, del pensiero immediato che non prevede conseguenze. Una forma arbitraria di narrazione della realtà che, paradossalmente, attraverso voci molteplici ha finito per dare vita non al pensiero ma al racconto unico.
Parafrasando ancora Underworld – ché anche l’attacco viene da lì – tenti di immaginarla, la parola, e non vedi la luce ardente di un oggetto, o di un sentimento, ma solo l’effetto che fa su uno schermo. (Roberto Manassero, Cineforum.it)